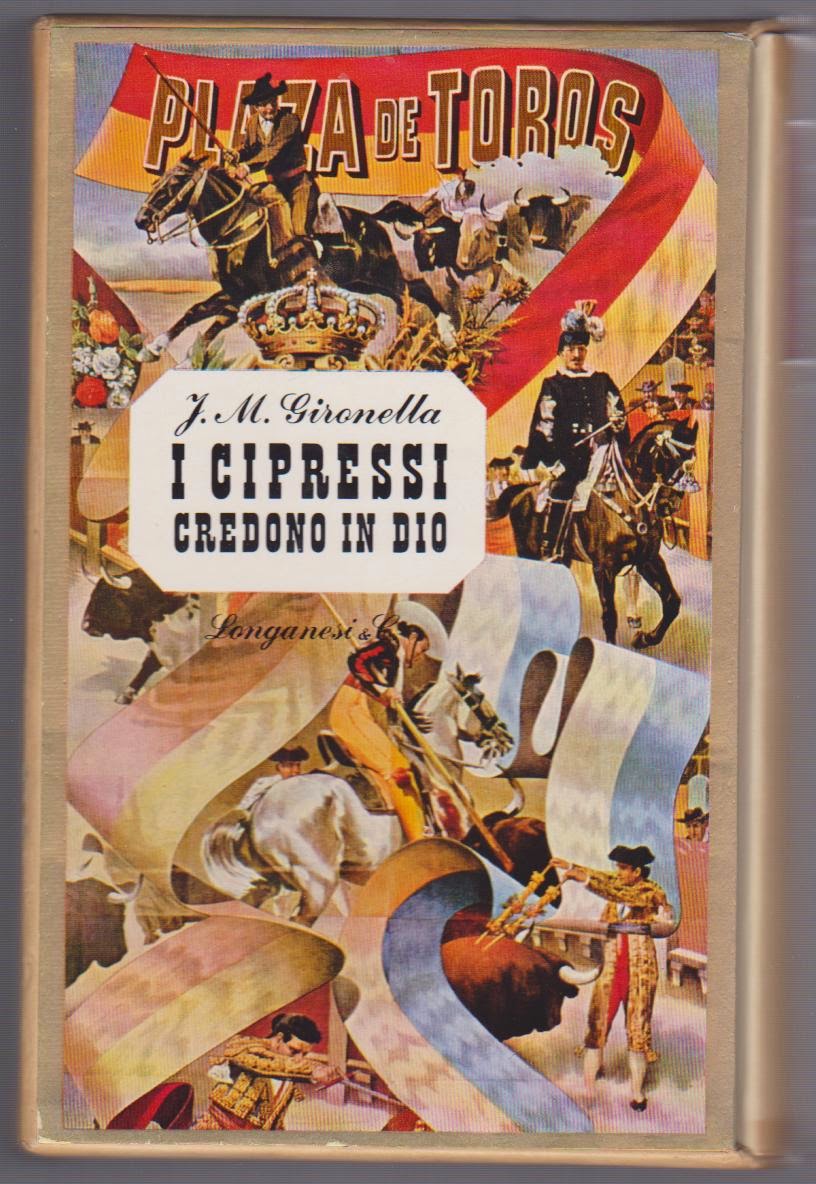Il libro della
settimana: Montesquieu, Tutte le opere
[1721-1754], a cura di Domenico
Felice, testo francese e fronte, Bompiani Il Pensiero Occidentale, Milano 2014,
pp. CCLI-2694, Euro 65,00.
Non è un "attacco" ( o "cappello") molto accademico, all’altezza
del Montesquieu, Tutte le opere [1721-1754] (Bompiani), nuova e curatissima edizione ad opera di Domenico
Felice, ma non possiamo contenerci: se, messi alle strette, dovessimo scegliere quale volume portare sulla famosa isola che
non c’è, sceglieremmo questa Bibbia protoliberale, che introduce, con
quella semplicità tipica delle grandi menti, ai misteri della sociologia,
della storia e della politica e molto altro ancora. Detto questo, indossiamo panni reali e curiali e così, condecentemente, vestiti, per dirla con un altro grande, occupiamoci del nostro tesoretto.
Innanzitutto il curatore,
Domenico Felice, professore associato di storia
della filosofia presso l'Università di Bologna (Dipartimento di Filosofia e Comunicazione), è
uno specialista di fama internazionale:
Prix de l'Académie Montesquieu 1991, Membro "associé" dell'Académie Montesquieu. Oltre alle numerose pubblicazioni
e curatele di e su Montesquieu, Felice anima un sito web (
www.montesquieu.it) ad alto tasso di
scientificità. Perciò dal punto di vista
filologico la raccolta è impeccabile, come del resto si evince dal ricchissimo apparato
critico, bibliografico, dalle Appendici ai testi, dalla invigilata riproduzione dei preziosi Indici degli Argomenti trattati, nonché dalla eccellente Introduzione. D'altra parte, tutto quel
che Bompiani pubblica nella splendida
collana “Il Pensiero
Occidentale” è delegato a studiosi di cristallina fama. Il che spiega l'elevata qualità scientifica di un progetto editoriale, ideato e diretto dal compianto Giovanni Reale.
Nel volume sono raccolte, in una nuova traduzione (a
cura di Domenico Felice, Riccardo Campi, Stefania Stefani,
Davide Monda, Piero Venturelli, Giovanni Paoletti, Rolando Minuti), le
opere pubblicate in vita da Montesquieu: le
Lettres persanes (1721), il
Temple de Gnide
(1725), le
Considérations sur les causes
de la grandeur des Romains et de leur décadence (1734), il
Dialogue de Sylla et d’Eucrate
(1745), l’
Esprit des lois (1748),
la Défense de l’Esprit des lois (1750), il
Lysimaque (1754) .
Dicevamo dell’ Introduzione di
Domenico Felice. E c’è un perché: siamo davanti a un’ottima traccia espositiva, di grandissima qualità, che favorisce la lettura e, per dirla tutta, facilita il lavoro del recensore, specie se umile sociologo come chi scrive. Innanzitutto, siamo d’accordo sulla
natura stratigrafico-evolutiva
del continente Montesquieu: nella sua vita mentale nulla è lasciato al caso, non smarrito procedere a tentoni o per prove ed errori, bensì un percorso di progressivo e ragionato approfondimento di alcuni temi iniziali
(poi esistenziali), legato, per successive approssimazioni, allo svolgersi della
sua esperienza esistenziale, segnata dallo
studio inteso, dai viaggi, ma anche dal
radicamento e dall'orologio, ora lento, ora più rapido, del vivere
pratico del giurista e
dell’amministratore.
Quali i temi di fondo? La dialettica tra dispotismo e
libertà, interpretata come corposa dinamica sociologica tra istituzioni
e individuo, ma anche quale frutto della
dialettica tra il carattere di un popolo e il divenire storico delle sue istituzioni; l’alternarsi di decadenza e progresso, quale conflitto
tra le ragioni della conquista e del ripiegamento vittorioso su stessi; il valore
della dignità umana, soppesato sulla bilancia dello stoico antico, ferito al cuore dalla lezione del cristianesimo e consapevole
della necessità di una giustizia
baluardo, autonoma, capace di mitigare, e
nel caso anche opporsi a ogni forma di assolutismo politico. Felice, parla, e con ragione, dello sforzo
gigantesco di creare una “scienza
universale dei sistemi politico-sociale” puntando su due ordini di cause: fisiche e morali. Di qui, i giudizi, per cui è famoso Montesquieu, sui rapporti
tra clima caldo e servitù politica, tra grandi spazi e assolutismo politico, tra quest’ultimo e la decadenza sociale ed
economica. Quindi cause fisiche, cause
morali, ma anche “accidentali” ed “essenziali”, sulla scia dei grandi anatomisti
sociali da Aristotele a Sorokin. Ecco un esempio del suo approccio, tratto
dalle Considérations sur les causes de la
grandeur des Romains et de leur décadence (1734):
Ecco
in una parola, la Storia
dei Romani. vinsero tutti i popoli con le loro massime; ma allorché ci furono riusciti,
la loro repubblica non poté più reggersi: si dovette cambiare governo, e
massime contrarie alle prime, adottate
nel nuovo governo, provocarono la caduta del loro governo. Non è la fortuna a
dominare il mondo: lo si può chiedere ai
Romani che ebbero un continuo succedersi di risultati favorevoli
quando si governarono secondo un certo progetto, e un susseguirsi
ininterrotto di rovesci allorché si comportarono secondo uno diverso. Ci sono
cause generali , sia morali sia
fisiche, che agiscono in ogni
monarchia , che la innalzano, la
mantengono o la fanno cadere; tutti gli accidenti sono sottoposti a
queste cause; e, se l’esito di una
battaglia, ossia una causa particolare, ha mandato in rovina uno Stato
vuol dire che esisteva una causa
generale per cui quello Stato doveva
perire a séguito di una sola battaglia, In una parola, il movimento
principale trascina con sé tutti gli
accidenti particolari (p. 771) .
Ecco un altro esempio tratto
dall’Esprit des lois , sempre a proposito dei Romani, dove però si parla anche di altro, in particolare dell’equilibro fra i poteri e degli effetti di ricaduta di un cattivo
bilanciamento:
Bisogna
sottolineare che i tre poteri possono
essere ben distribuiti in rapporto alla
libertà del cittadino, ma non esserlo altrettanto bene in rapporto alla libertà
de cittadino. A Roma, poiché il popolo
deteneva la maggior parte del potere legislativo, una parte del potere
esecutivo e una parte del potere giudiziario, si trattava di bilanciare un grande potere con un altro. Il senato
aveva sì una porzione del potere esecutivo e qualche ramo del potere legislativo, ma ciò non era
sufficiente per controbilanciare il popolo. Bisognava che il senato prendesse
parte al potere giudiziario, e vi
prendeva parte quando i giudici erano
scelti tra i senatori. Ma allorché i Gracchi privarono i senatori del potere giudiziario, il senato
non poté più resistere al popolo. Essi
colpirono dunque la libertà della costituzione per favorire la libertà del
cittadino, ma questa si perdette con quella (p. 1269).
Montesquieu intuisce che la “pesantezza” del politico viene sempre dopo quella
della società, da lui vista come processo interattivo fra istituzioni, ceti, classi: ( pre-durkemiani?) blocchi di rappresentazioni istituzionali e sociali che finiscono per essere più forti degli uomini che ne fanno parte. Di qui, la necessità, per evitare forme di
monopolio politico, di trovare una buona sintonia, storica e sociologica, fra istituzioni e credenze. Il famoso equilibrio dei poteri. Una "tregua" procedurale? Non soltanto. Forse, anche correndo il rischio di forzare il suo pensiero o semplificarlo troppo, crediamo che Montesquieu abbia in qualche misura anticipato, come nel passi citati sui Romani, il concetto di costituzione materiale (da affiancare a quello di formale): non solo forme giuridiche, per mitigare, dividere il potere e "proceduralizzarlo", ma anche idee e forze sociali che progrediscono con, attraverso e contro gli uomini. Una mappa dei poteri sociali (non strettamente politici (in senso essenzialista), sui quali Montesquieu si libra raggiungendo altezze degne dell' aquila reale, come provano le sue canoniche indagini tese a stabilire il principio (“ciò che lo fa agire”) e la natura (“ ciò che lo fa essere quello che è”) delle tre principali forme politiche individuate, esito del suo sapere trasversale (non solo giuridico-legalistico, insomma): repubblica ( principio: virtù politica;
natura: governo di molti), monarchia (principio: l’onore; natura: governo di
molti), dispotismo (principio: governo
di uno solo, senza vincoli di legge; natura: paura).
Sotto tale aspetto non
condividiamo( o condividiamo solo a metà)
le critiche mossegli da uno studioso che per altri aspetti apprezziamo, Julien Freund,
il quale nell’Essence du politique, accusa Montesquieu di formalismo. Gli rimprovera di cloroformizzare giuridicamente il
ruolo dirompente della ragion politica. Ciò in
parte è vero, ma dipende dal fatto che Montesquieu, a sua volta, crede nella ragion
sociologica: nella "forza", come ricordato, della costituzione materiale e morale di una società. Sintetizzando, forse troppo, all’ “auctoritas non veritas facit legem” di
Hobbes, Montesquieu oppone un “veritas (sociologica) non auctoritas facit legem”…
Ovviamente, il nostro è solo un modesto
spunto interpretativo, debitore delle classiche pagine di Aron su Montesquieu, giustamente ricordate da Felice nella finissima Introduzione. Insomma, un pensiero ricco e arioso, che si confronta con la "pesantezza", talvolta claustrofobica del sociale. Di qui, l'importanza di leggere o rileggere Montesquieu. Diremmo il dovere, soprattutto in un momento storico, come il nostro, in cui il paventato dispotismo orientale, sul quale Montesquieu ha scritto pagine definitive, sembra incombere su di noi, come ha provato il terribile eccidio di Parigi. Insomma, se ci si perdona il tono: lettore avvisato, mezzo salvato. Crisi o non crisi, correre subito il libreria. È un ordine. O quasi.
Carlo Gambescia