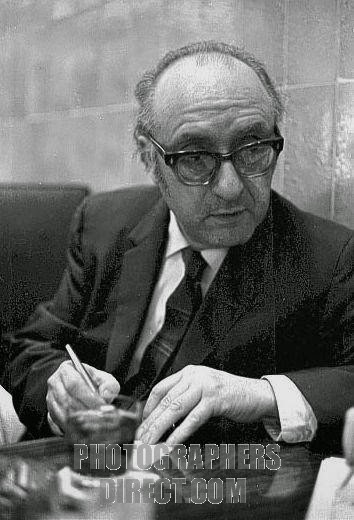Profili/19
Gino Germani
Gino Germani (1911-1979) è un esempio di come si possa
essere studiosi di politica, senza però cadere nella trappola degli specialismi
e soprattutto del "presentismo" politologico. Che si intende con questo termine?
Si indica una politologia (ma il problema oggi riguarda tutte le scienze
sociali), come quella attuale, ripiegata quasi esclusivamente sullo studio del
"presente" (e delle sue implicazioni temporali immediate, dai cicli
elettorali a quelli politico-economici), come unica realtà meritevole di essere
approfondita. E quel è che più grave è che il "presente" - e
soprattutto le sue forme politiche (che riflettono le istituzioni consolidatesi
nell'Occidente euro-americano dopo due guerre mondiali) - spesso viene
utilizzato ideologicamente da larga parte della politologia contemporanea in
modo acritico e astorico come modello storico per giudicare tutte le forme
politiche del passato, del presente e del futuro.
Gino Germani nasce a Roma nel 1911. Figlio di un sarto
socialista e di una madre di origine contadina e fervente cattolica. Studia
ragioneria e nel 1930 si iscrive alla Facoltà di Economia e Commercio. Ma lo
stesso anno viene arrestato e condannato a cinque mesi di prigione per aver distributo
letteratura antifascista. Nel 1934, poco dopo la morte del padre, per evidenti
ragioni economiche e politiche, emigra con la madre in Argentina. Nonostante la
giovane età, oltre al ricordo di Roma e dell'Italia, porta con sé un notevole
bagaglio intellettuale di letture e interessi, musica, filosofia, scienze
sociali. Nel 1938, dopo aver provato a continuare gli studi di economia, decide
di iscriversi alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Buenos
Aires (UBA). Dove grazie a Ricardo Levene, titolare all'epoca dell'unica
cattedra di sociologia dell'UBA, scopre la sua vocazione di sociologo e
scienziato politico. Negli anni Quaranta studia intensamente, fonda e scrive su
riviste antifasciste, scopre e fa tradurre, introduce i classici della
sociologia europea e americana, lavora per il ministero dell' Agricoltura e in
campo editoriale. Addirittura si occupa del "Correo Sentimental", la
rubrica di piccola posta della rivista "Idilio", rispondendo alle
lettrici. E' un "hombre multifacético", pur conservando un forte
accento italiano, parla fluentemente lo spagnolo e conosce molte lingue (
giungerà a scrivere libri e articoli direttamente in spagnolo, italiano,
francese, inglese, portoghese). Uomo dall' intelligenza acutissima, lettore
onnivoro e dotato di visione storica profondissima, oltre che sociologica.
Soffre la dittatura di Peron. E sale perciò in cattedra solo nel 1955. E nei
successivi undici anni (1955-1966), quale capace organizzatore non può non
lasciare una forte impronta sul processo di istituzionalizzazione della
sociologia argentina (crea cattedre, fonda istituti, promuove ricerche, forma
discepoli, prende contatti con l'estero ). Acquisisce fama internazionale. Si
reca spesso, invitato, negli Stati Uniti, dove tiene corsi all'Università di
Harvard. Nel 1966, dopo il colpo di stato, lascia l'Argentina proprio per
Harvard. Nel 1976 si traferisce in Italia, torna a vivere nella sua Roma,
mantenendo però l'insegnamento americano. Ottiene una cattedra all'Università
di Napoli, dove insegna fino al 1979, anno in cui muore.
L'impianto teorico della sociologia di Germani è di tipo
struttural-funzionalista, e leggendo i suoi libri si avverte il forte influsso
, oltre che di alcuni classici (Durkheim, Pareto, Weber), della sociologia
parsoniana. Senzà però dimenticare il ruolo giocato nel suo pensiero da Marx e
Freud. Questa sua scelta "americana" gli attirò purtroppo critiche in
Argentina, a destra e sinistra: per i primi la sua sociologia era
"antinazionale", per i secondi "serva" degli statunitensi.
Mentre in realtà nelle sue opere Germani si è soprattutto sforzato di capire,
da vero teorico, partendo da un impianto olistico (la società come un tutto),
la reale portata sociologica di fenomeni come la modernizzazione, la
secolarizzazione, il totalitarismo. Certo, non in chiave
"presentistica", come puri e semplici fatti politici e sociali
appartenenti a fasi di sviluppo precedenti: reperti archeologici sui quali gli
scienzati sociali non devono indugiare più di tanto. Ma come costanti di tutte
le società umane, e soprattutto come fenomeni connessi ai processi di
disorganizzazione, organizzazione e rioganizzazione sociale. Dei quali la
modernità è certo portatrice, senza per questo dover autorappresentarsi come
l'unica depositaria dei valori di una specie di "migliore dei mondi
possibili". Perciò Germani, non segue fino in fondo la sociologia di
Parsons: non ne condivide l'ottimismo storico. Inoltre, per quel che concerne
lo studio della società moderna Germani riprende e sviluppa il problema fondamentale
della sociologia classica, quello dell'ordine sociale . A suo avviso le
tensioni strutturali tipiche delle democrazie e della società moderne, nascono
dalla tensione tra sviluppo crescente dei processi di secolarizzazione e
perdurante necessità di un nucleo di valori condivisi e prescrittivi, ai quali
nessuna società può rinunciare, pena la sua disintegrazione. Insomma, Germani è
consapevole che senza un punto di riferimento comunitario, sociopsicologico,
identitario (e non puramente contrattualistico) capace dunque di trascendere
l'individuo, senza però tradirne il consenso, nessuna società è in grado di
guardare con fiducia al futuro: di crescere e perpetuarsi. E questo spiega
perché oggi le scienze sociali, in quanto riflesso di una società priva di un
nucleo comunitario, siano così passivamente ripiegate sul presente.
Tra le sue opere ricordiamo: Estructura social de la Argentina (1955);
Estudios del Psicologia Social (1956); La sociologia en America Latina
(1964); Politica y sociedad en una epoca de transicion (1965, trad.
it. parziale Sociologia della modernizzazione, Editori Laterza, Bari
1971); Sociologia de la modernizacion (1971, trad. it, parziale,
Sociologia della modernizzazione, cit.). In italiano si veda anche
Autoritarismo, fascismo e classi sociali , il Mulino, Bologna 1975);
Saggi Sociologici a cura di A. Cavicchia Scalamonti e Luis Sergio Germani,
Edizioni Libreria dell'Ateneo di G. Pironti, Napoli 1991 (con un'importante
bibliografia delle opere, articoli e saggi, pubblicati da GG). Va infine
ricordato il "Centro Gino Germani di Studi Comparati sulla
Modernizzazione", che dispone di una ricca biblioteca diretta dal figlio,
dottor Luis Sergio Germani, (Via Della Dogana Vecchia, 5 - Roma 00186 telefax
066876878). Il Centro, di cui è presidente il sociologo, professor Luciano
Pellicani, pubblica il quadrimestrale "Modernizzazione e Sviluppo
Carlo Gambescia